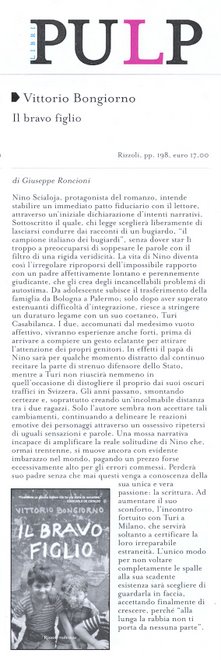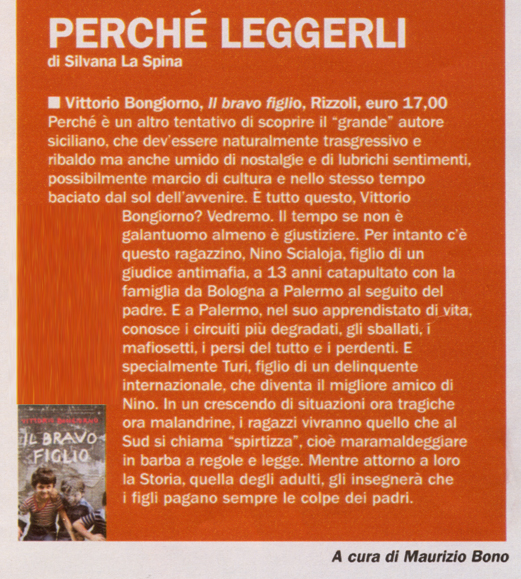Dice che "Io non sono come te"...
Dice che "Io non sono come te" è il racconto che ho finito di scrivere nei giorni in cui, a dicembre dello scorso
anno, ero stato invitato all’Italian Bookshop di Londra per la presentazione
del mio romanzo “Il Duka in Sicilia”, di cui questo racconto è in qualche modo
“figlio”.
Mi ero
perso in una delle mie infinite passeggiate in una pungente mattina per
ritrovarmi a Camden Town nello stesso luogo in cui, più di vent’anni prima,
avevo comprato con mia sorella il primo “Chiodo”, i Doc Marten’s e i 45 giri
dei Police. Del quartiere “maledetto” dei Clash e di “Whithnail & I” non
c’era più traccia, e mi stavo nuovamente infilando le cuffiette dell’iPod
quando mi sono imbattuto in un tizio che suonava un pianoforte mezzo distruttosul marciapiedi davanti a un negozio di memorabilia. Aveva qualcosa di strano
eppure di familiare: benché fosse inverno non portava calzini, i pantaloni alle
caviglie, un giubbotto di pelle leggero, ma soprattutto aveva un modo di
suonare che io conoscevo molto bene. Era un pezzo strumentale, e batteva il
tempo con il tacco del mocassino premendo i tasti come se li volesse aggredire.
Il pianoforte non era uno strumento staccato da sé, il pianoforte era una parte di sé, che viveva con lui,
suonava con lui, sbagliava con lui. Perché sì, a un certo punto si era
impappinato, e anche quel gesto io lo conoscevo bene. Sembrava che stesse per
morire, e che quella era l’ultima volta che avrebbe potuto suonare e gridare a
squarciagola “I need your love”. Finita l’esibizione mi ero allontanato ed ero
scoppiato a piangere. Avevo trovato Noah, il bambino protagonista del racconto
che avevo appena spedito all’editore via email mezzora prima. è una cosa difficile da spiegare, che
ha a che fare con la disperata solitudine della creazione di una storia e dei
suoi personaggi, e la possibilità di toccare l’infinito con mano, e di sentirlo
reale. Nessun premio letterario può arrivare a così tanto, a così in alto, e
così intensamente. L’emozione era stata troppo forte, e per assurdo che possa
sembrare, ho contattato via facebook Stephen Ridley, il pianista di Camden
Town, solo una volta tornato in Italia.
A casa,
a Bologna, quasi dieci anni prima, dopo l’ennesimo “cambio di vita”, mi ero
trasferito a qualche portone di distanza da un negozio di bellissime scarpe
artigianali disegnate da una stilista londinese che vedevo passare ogni tanto
nascosta sotto grandi coloratissimi cappelli. In questi anni il sogno di Debbie
Baker si è trasformato nel successo internazionale del brand Fiorentini+Baker,
anche grazie, perché no, alle decine di scarpe che ho comprato io! L’invito di
Debbie e di Marisa Bernardoni a portare il reading musicale del mio “Duka” nel
loro negozio sotto casa è stato un piacere e un onore: anche le loro scarpe
raccontano una storia, fatta di tradizione e di invenzione, esattamente lo
stesso “conflitto” di cui si parla nel mio libro. E dopo Bologna, il “Duka” è
arrivato anche da Fiorentini+Baker New York, grazie alla pazienza e
all’entusiasmo di Cristina Guidetti.
Che
fine ha fatto il pianista di Camden Town? Avevo raccontato a Debbie e Marisa la
mia idea di organizzare un concerto a Bologna di Stephen, anche se in fondo, a parte qualche video su
YouTube, non sapevo nulla di lui, né della sua musica. L’idea era bella, ma
Debbie era dovuta partire per Londra per lavoro, e ne avremmo riparlato al suo
ritorno. Non mi aveva detto che, curiosa, sarebbe andata a sentire quel pazzo
pianista che “trascinava il suo piano in giro per il mondo portando l’amore tra
la gente”. E una mattina, come solo in certi film e certi libri accade, Marisa
mi ha mandato un video di una turista asiatica che riprende Stephen in una
delle sue strazianti performance: la turista, ignara di essere mossa dal caso,
a un certo punto gira la telecamera e inquadra Debbie, che fuma una delle sue
sigarette, sotto uno dei suoi stupendi cappelli.
Dice che Stephen
ha suonato per Fiorentini+Baker a Bologna, nella piazza davanti al negozio, e a
Londra, per strada a Notting Hill. E questo grazie a Josef, Daniel e Noah. Lo
so, sono uno scrittore, e questa sembra una storia inventata. Ma, credetemi,
non è così. È tutto vero. Anche stavolta ogni riferimento a persone e fatti è
puramente casuale.
Dice che Stephen suonerà anche sabato 29 settembre a Parigi.
.jpg)