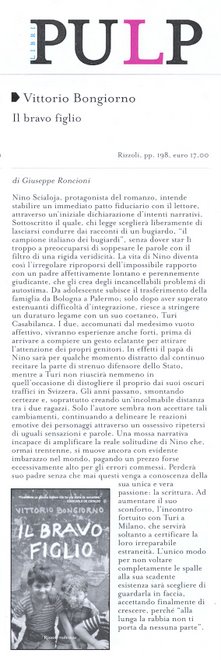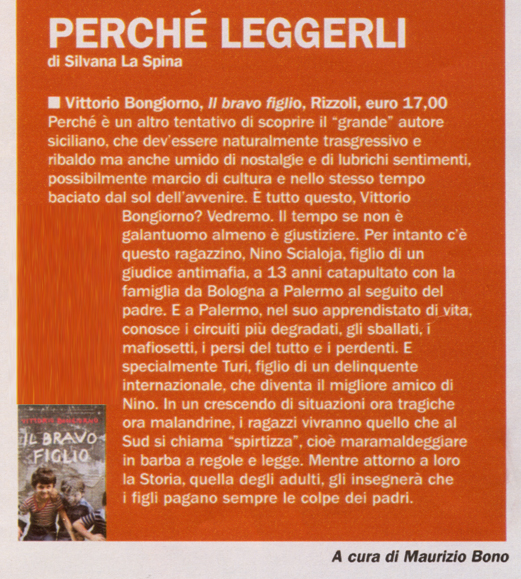Don’t tell the river: Mick Turner live in Bologna
Freakout Club, 14.9.14
L’altra volta che Mike Turner era venuto con i
Dirty Three a Bologna facevano tanto di quel casino che avevano letteralmente
coperto una delle scosse di assestamento del terremoto. Ma stasera c’è la
chitarra, pedalini colorati e batteria. Niente barbuto, niente violino, niente
casino.
In verità non c’è proprio un cane quando
arriviamo. Locale deserto, tanto che dopo mezzora chiedo al tipo all’ingresso:
dice che i ragazzi sono andati a casa a farsi una doccia e arrivano. Il giovane
Kafka seduto sulla panca accanto alla mia mi guarda sconsolato. Gli vorrei dire
che ci sono passato anche io, la vita è uno schifo, menomale che c’è la musica
di Mick Turner. C’è pure il microfono, stasera! Si sarà messo a cantare?
“Ho sognato che morivo. Volteggiavo sopra le
dune verso l’oceano, era mattina e la nebbia sull’acqua era così fitta”: si
chiama così il dipinto di copertina, realizzato da lui stesso, come per gli
album del terzetto, per il suo nuovo lavoro solista “Don’t tell the river” (Drag City). Fatto tutto da solo, col altri
amici, senza né il barbuto, senza nemmeno il batterista “polpo” Jim White,
l’unico al mondo capace di suonare tutti i tamburi e piatti contemporaneamente
con due sole bacchette (e le sedici mani).
“Ciao,
io sono Mick, lui è Mike”, fa
lui quando sale sul palco. Non sembrano due che si sono fatti la doccia, e
questo è tutto quello che dice al microfono.
Parte il primo giro, messo in loop con un
pedalino bordò, su cui registra una
seconda chitarra, e poi una terza, e dopo pochi minuti dall’inizio, sono sordo.
Ma felice. Investito da un muro di suono doloroso ma vivo. Kafka, accanto a me,
è impassibile.
Dietro le pelli non c’è il “polpo”, ma un
giovane batterista in tenuta da rockstar che picchia duro e si inventa dei bei
passaggi che tengono testa ai loop dell’amico Mick.
Le canzoni non sono canzoni, sono grumi di note
che si addensano alla velocità della luce, e che poi esplodono, inquieti. È una
tela su cui Mick (con Mike) imprime tutti i colori possibili che ha a
disposizione, ne unisce i filamenti creando nuovi impasti sonori, si sporca le
mani fino ai gomiti, fino a che tutto non resto sullo sfondo, un magma
indistinto, su cui schizza gli ultimi tocchi di luce, grappoli di note che
rischiarano la notte.
Poi spegne la loop-station, ringrazia, e se ne
va.
Poi torna, dice che fa un pezzo dei Dirty Three
da solo, non si capisce quale, mentre il batterista impomatato si intorta la
barista, il giovane Kafka soffre in silenzio e un giovane Hemingway finisce di
rollare una canna preparata tutto il concerto e la accende, come se niente
fosse, mentre sfilano le note di sottofondo di questa notte obliqua. La vita è
uno schifo, e non c’è tempo da perdere in canzonette, e Mick lo sa, per questo
suona tutto il suonabile, tutte le note possibili, come un Coltrane sonico
australiano e allampanato e se ne va lasciando metà del pubblico senza
fiato (l’altra metà è uscita a fumare a metà concerto e non è più tornata).
Grazie Mick (e Mike). Torna presto.
© vittorio bongiorno